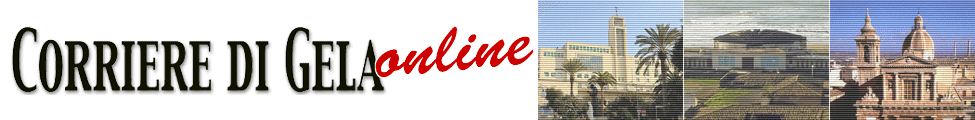 |
||||||||||||
|
notizia del 24/03/2013 messa in rete alle 19:12:33
La settimana santa, tra riti religiosi e tradizioni popolari Mancano pochi giorni alla settimana Santa in città, una celebrazione dalle origini antiche e difficile da datare. Si pensi che già nel periodo federiciano si celebravano i misteri della Chiesa e che Martino il Giovane, Re di Sicilia, celebrava tutti gli anni l’episodio dell’ultima cena. Si ha perfino notizia che nel 1440, ai tempi dei Vicerè, si ricordava in Sicilia la Sacra rappresentazione della Passione. Il folclore in città viene avvertito dai fedeli, che anticipano la settimana Santa con esercizi spirituali che vanno sino alla domenica delle Palme. Quest’ultima ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, ed è con la Domenica delle Palme che le attività religiose entrano nel vivo, con i devoti che aderiscono alle funzioni religiose nella chiesa Madre e nelle altre chiese. Ma quali sono gli aspetti più tradizionali della Pasqua in città? Lo abbiamo chiesto ad Emanuele Zuppardo (nella foto), storico e cultore di tradizioni popolari sin da ragazzo. «Sono i canti – sostiene Zuppardo – l’aspetto più tradizionale della settimana Santa, che interpretano il significato di una settimana di passione, densa di episodi, espressioni e immagini custodite nel cuore della gente. Conoscere i canti – continua – significa riscoprire se stessi e diventare protagonisti di una rappresentazione drammatica, che si tramanda da secoli senza che i testi siano mai stati scritti da alcuni, ma tramandati in maniera orale». Una delle tradizioni non praticate da più di un ventennio, ci racconta Zuppardo, è quello de “l’uffizio delle tenebre”, dove le porte e le finestre della Chiesa Madre venivano chiuse, e nel semibuio e nel silenzio più assoluto, si udivano frastuoni di grosse catene e rumori di “tròcculi ‘i lignu”. Il buio stava a significare il mondo che sprofondò durante la passione, mentre il rumore dei “tròcculi” e delle catene ne indicavano l’arresto. Il giovedì santo viene contraddistinto dal via vai di gente verso la Chiesa del Rosario per il tradizionale bacio dei piedi, mentre alla sera il celebrante compie il rito della lavanda dei piedi a dodici uomini che impersonificano gli apostoli. Dopo la funzione religiosa ha luogo il rito della riposizione del SS. Sacramento nell’altare dove è sistemato il sepolcro e, al canto del “Pange Lingua”, ha inizio la processione. I fercoli del Cristo e dell’Addolorata vengono portati a spalla per le vie della città. Il lamento viene intonato fin sotto il Calvario, dove il Cristo viene appeso in croce. «Al calvario – racconta Zuppardo – l’affluenza è impressionante e la calca registra tutt’oggi presenze mai verificate. L’urna dorata che deve ospitare il corpo del Cristo morto – continua – si avvia dal corso Vittorio Emanuele verso il Calvario, accompagnato da rappresentanze religiosi e civili, dalla banda musicale e dai “lamentatari” e dalla folla dei fedeli. Da sempre, nessuno dei “lamentatari” sa quello che dice, perché è stata fatta una traduzione dal latino al gelese, senza prima passare dall’italiano». La sera avviene la deposizione del Cristo nell’Urna che si muove verso il corso principale della città sino in Chiesa Madre dove il sabato Santo si tengono i funerali di Gesù. È a mezzanotte, tra un’esplosione a festa di campane di tutte le chiese, che Cristo risorge. «Da sempre appassionato in materia – dice Zuppardo – credo che le tradizioni siano il tabernacolo del popolo, dove esso custodisce religione e storia, fatta di angherie e soprusi ma anche di gioie e speranze. Trovo che la religiosità del popolo gelese sia rimasta immutata nel corso degli anni, la popolazione è molto legata e molto devota. Quasi nessuno – continua – infatti si esime dall’andare al Calvario per una preghiera. In città è il venerdì Santo la festa per eccellenza, anche se si celebrano la passione e la morte di Gesù Cristo. Il venerdì è il giorno di digiuno e di riposo e tutt’oggi sono in molti a non voler fare i turni nelle aziende. Paradossalmente – racconta – la domenica viene poco sentita, esce poca gente, essendo essa diventata figlia del consumismo. C’è da notare inoltre che a Gela la domenica non hanno mai avuto luogo le processioni, mentre in molti comuni siciliani sono tutt’ora in vigore processioni del simulacro del Cristo risorto. Ciò significa probabilmente – conclude – che a Gela si celebra soltanto la commemorazione del mistero del dolore e non quello della resurrezione». Dal punto di vista delle tradizioni culinarie, Zuppardo racconta che a Gela non ve ne siano state mai di radicate. La maggior parte di esse sono state importate, come le uova di pasqua e l’agnello di frutta martorana, che giunge da Palermo. L’unico dolce tradizionale consisteva nell’uovo di cioccolato conosciuto con il nome di “’u pupu ccu ll’ovu” donato ai più piccoli quando facevano ai grandi gli auguri con il tradizionale bacio della mano. Autore : Vanessa Ventura » Altri articoli di Vanessa Ventura |
In Edicola |
Newsletter |
||
Cerca |
||
|
||
| Informa un Amico | |
| Stampa la Notizia | |
| Commenta la Notizia |
| 㯰yright 2003 - 2025 Corriere di Gela. Tutti i diritti riservati. | Powered by venturagiuseppe.it |

